Un’utopia ambigua, questo c’era nel titolo inglese The Dispossessed. An Ambiguous Utopia (1974), tradito dal titolo della versione italiana. Nel canone delle utopie/anti-utopie della fantascienza classica del secondo Novecento, Le Guin costruisce un laboratorio con molteplici livelli di lettura che tornano utili oggi che i nostri modelli di convivenza sono molto stressati dall’interno.
Anarres è una luna dove i seguaci della rivoluzionaria Odo sono trasferiti da Urras, come accordo politico che chiude la rivolta entro un esilio concordato. Gli anarresiani-odoniani danno vita a una società basata su principi anarchico-egualitari basati da un lato su una raffinata programmazione sociale e dall’altro su un profondo rispetto per la libertà individuale: una società, quindi, senza Stato, pressocché senza leggi in cui si i partecipanti sono guidati da un puro spirito di solidarietà e coordinamento volontario. Su Urras, invece fiorisce una società capitalistica, “proprietaristica”, predatoria e militarista nella nazione di A-Io, che sfrutta le risorse minerarie raccolte dagli anarresiani e altri più piccoli e tumultuosi insediamenti in perenne lotta tra loro. Urras e Anarres sono rigidamente separate, solo pochi navi mercantili fanno la spola dall’uno all’altra perché, in un certo qual modo, gli urrasiani temono il contagio ideologico degli odoniani.
Quasi due secoli dopo l’insediamento, Shevek, giovane fisico teorico di Anarres, elabora una geniale teoria generale del tempo e della simultaneità che potrebbe rendere possibile un avanzamento tecnologico altrimenti impossibile. Su Anarres però Shevek non riesce a completare e a divulgare la teoria perché si scontra con il “muro” delle consuetudini scientifiche e sociali che, nella sostanza se non nella forma, creano una struttura gerarchica ostile alle nuove idee. Grazie ad una pubblicazione semi-clandestina, vincerà un premio e verrà accolto su Urras, dove le autorità sperano di sottrarre la sua invenzione e poterci lucrare sopra.
La narrazione è un montaggio alternato di capitoli che funzionano come una struttura di comparazione, attraverso gli occhi del personaggio che da un lato racconta la sua evoluzione su Anarres, fino alla fuga su Urras, e dall’altro la sua permanenza su Urras fino a un esito inatteso.
Al lettore, ogni scelta di Shevek nei capitoli su Anarres può sembrare guidata dall’esperienza accumulata dai capitoli, futuri nel tempo, su Urras, e non solo viceversa – rendendo reale per il lettore l’ipotetica teoria fisica del tempo e della simultaneità. Un contrappunto straniante che racconta la sostanziale uniformità strutturale del potere, indipendentemente dalla sovrastruttura politica che viene imposta nel governo.
L’ambiguità nel romanzo è strutturale e non riguarda solo il superficiale confronto tra i modelli politici diametralmente opposti che finiscono per equivalersi. Il romanzo rifiuta però l’ingenua opposizione tra libertà e coercizione.
Tante, e utili al contesto attuale, le letture di quest’affresco leguiniano. Ad esempio, la vicenda accademica di Shevek è al tempo stesso una teoria del valore di ciò che oggi è Scienza e contemporaneamente un’acuta critica delle istituzioni accademiche moderne. Su Anarres il controllo del pensiero non passa da brevetti e denaro, ma da reputazione e “filtri” soft, impersonificati dal supervisore Sabul che incarna il potere di chi amministra canali e reti: non però un censore ideologico, ma un manutentore della scarsità cognitiva che egli stesso genera. Su Urras, il controllo passa da patronage, proprietà, diplomazia accademica, dal potere dei soldi e dello Stato. Con un efficace uso del chiaroscuro Le Guin dipinge, ad esempio, un affresco in cui per entrambe le società il vero sapere è catturato e reso inefficace da una sovrastruttura di potere con strumenti di cattura e e valvole di sfogo differenti. Amara la considerazione che traspare tra le righe che seppure è vero che la chiusura al sapere diventi sterilità, non basta una apertura, quale che sia cioé senza adeguate garanzie, per non far diventare questo sapere solo uno sfruttamento incivile, che l’autrice rappresenta come l’uso urrasiano della scienza a fini bellici e per la repressione civile.
Qui, l’ambiguità diventa un vincolo etico: obbliga a giudizi locali, a compromessi revocabili, a doveri di manutenzione; ma è un’ambiguità senza relativismo. Questa è la forza del libro oggi: insegna a resistere a protocolli morali binari ed esplorare criteri situati e pronti a essere continuamente riformati.
The Dispossessed è anche una storia sulla solitudine non tanto del genio, ma di tutti noi; sulla difficoltà di dosare opportunamente condivisione e privacy (un’esperienza tragicamente simile all’esposizione nelle reti sociali odierne). È anche una storia sulla diversità, sull’inclusione e sulla costruzione di strutture sociali intenzionali, cioé non obbligate dalla pressione sociale, o che a questa deliberatamente resistono, come i nuclei familiari o i gruppi d’interesse anarresiani.
In questi mondi, Urras e Anarres, dove tutto sembra possibile, per quanto in modi diametralmente opposti, il vivente resta sempre in balia della propria singolarità, della morsa del proprio corpo e, con un bell’esercizio di kantismo radicale, della morale che ha sviluppato dentro di sé.
Alla fine, nel libro non ci sono ricette, ma buone pratiche per la manutenzione istituzionale della libertà. La manutenzione diventa un lavoro invisibile che tiene in vita protocolli e istituzioni: liste, turni, riunioni, comunicazioni anche inattese, correzioni, scuse pubbliche, sanzioni leggere o meno leggere.
Il libro è un invito a considerare valide le consuetudini di protocolli continuamente riformabili, documentati, sottoposti a valutazione collettiva e accordo intersoggettivo. Questo è il cuore di una “lettura anarchica” dell’anarchismo Odoniano che non è assenza di regole, ma una loro artificialità vigilata. Un’artificialità seriamente egualitaria e orientata alla cura, radicate nell’eredità della fondatrice, Odo, che Le Guin dipinge con il suo tipico “tocco” di femminismo anarchico.
Forse c’è anche una morale valida oggi, in questi tempi di opulenza tecno-cognitiva: la materialità di Anarres, pianeta arido con risorse scarse e logistica difficile, crea quest’utopia odoniana praticabile solo per via dalla povertà condivisa e della durezza delle condizioni vitali. Anarres non è certo un paradiso. Invece, l’abbondanza urrasiana diventa continua fonte di guerra e disparità sociale. Nel panorama fantascientifico classico questo capovolge molte utopie tecnologiche. Se la scarsità è elevata a “virtù” teleologica, la critica dell’eccesso tecnologico scivola nel sospetto verso l’innovazione: se l’abbondanza, come è data oggi, diventa madre del “diritto di fare”, non saranno mai visibili i costi “ecologici” ed “egologici” dell’innovazione senza limiti.
Bonus track:
Le Guin, figlia di antropologi, in dialogo con l’ipotesi di relatività linguistica di Sapir-Worf, si dilunga nell’analisi del pravico, la lingua di Anarres, dove il possesso, anche solo grammaticale, è scoraggiato per ridurre lo spazio dell’“egoizzazione”. Il pravico, il cui lessico è la più evidente infrastruttura politica del romanzo, redistribuisce l’attenzione linguistica verso ciò che è condivisibile. Non è un dettaglio di colore, ma un aspetto al tempo stesso tecnologico e teologico di comportamento. Eppure questa lingua progettata per sminuire l’ego, finirà per irrigidirsi in un moralismo del “noi” e diverrà chiaro che la repressione dell’Io produce forme indirette di potere simbolico. Non casualmente per giungere al suo risultato, Shevek dovrà utilizzare lo iotico, ovvero la lingua di A-Io su Urras. L’impressione è che non avrebbe potuto riuscirci in pravico: significa che senza Io anche la cosa che ci sembra più condivisa, come la scienza, si blocca?
—
Ursula K. Le Guin – I reietti dell’altro pianeta
Pubblicato nel 1974, I reietti dell’altro pianeta (The Dispossessed. An Ambiguous Utopia) intreccia l’itinerario del fisico Shevek con il confronto fra due mondi gemelli: Anarres, colonia odoniana anarchica e scarsa di risorse, e Urras, opulento e gerarchico. La scoperta teorica di Shevek — che apre a un fondamentale avanzamento tecnico — diventa il banco di prova per interrogare proprietà del sapere, istituzioni, linguaggio e lavoro: due sistemi che si specchiano e si criticano, senza offrire comode assoluzioni. L’ambiguità qui è un metodo: Le Guin mette in scena come regole, consuetudini e protocolli producano realtà diverse, e come la libertà dipenda dalla capacità di riformarli. Per l’edizione italiana aggiornata si veda Oscar Mondadori; per l’inglese, l’edizione del 50° anniversario con la nuova prefazione di Karen Joy Fowler. (I reietti dell’altro pianeta – Ursula K. Le Guin)
Ursula K. Le Guin (1929–2018)
Scrittrice cardinale della narrativa del secondo Novecento, Le Guin ha costruito cicli diversi per ambizione e tono — dall’Ecumene/Hainish a Earthsea — unendo rigore antropologico, invenzione linguistica e un’attenzione politica mai didascalica. Pluripremiata (Hugo, Nebula, Locus), è fra le pochissime autrici ad aver rinnovato insieme l’utopia politica, il romanzo di formazione e il racconto di mondi “altri”, facendo della lingua e delle istituzioni gli strumenti veri della speculazione. (Ursula K. Le Guin – Scheda autore e Libri)
I reietti dell’altro pianeta – Ursula K. Le Guin – Mondadori: Collana Moderni ISBN: 9788804796718 432 pagine Prezzo: € 14,50 2025
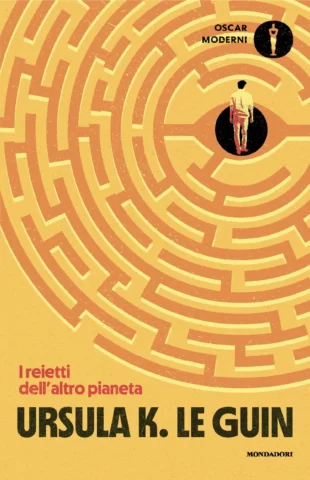
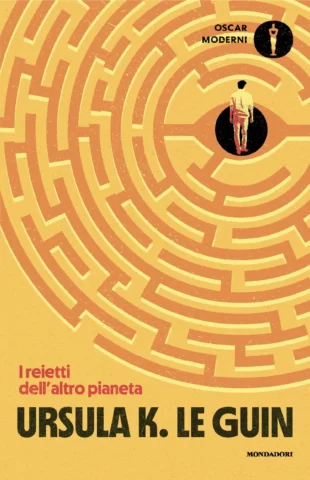
Un’utopia ambigua, questo c’era nel titolo inglese The Dispossessed. An Ambiguous Utopia (1974), tradito dal titolo della versione italiana. Nel canone delle utopie/anti-utopie della fantascienza classica del secondo Novecento, Le Guin costruisce un laboratorio con molteplici livelli di lettura che tornano utili oggi che i nostri modelli di convivenza sono molto stressati dall’interno.
Anarres è una luna dove i seguaci della rivoluzionaria Odo sono trasferiti da Urras, come accordo politico che chiude la rivolta entro un esilio concordato. Gli anarresiani-odoniani danno vita a una società basata su principi anarchico-egualitari basati da un lato su una raffinata programmazione sociale e dall’altro su un profondo rispetto per la libertà individuale: una società, quindi, senza Stato, pressocché senza leggi in cui si i partecipanti sono guidati da un puro spirito di solidarietà e coordinamento volontario. Su Urras, invece fiorisce una società capitalistica, “proprietaristica”, predatoria e militarista nella nazione di A-Io, che sfrutta le risorse minerarie raccolte dagli anarresiani e altri più piccoli e tumultuosi insediamenti in perenne lotta tra loro. Urras e Anarres sono rigidamente separate, solo pochi navi mercantili fanno la spola dall’uno all’altra perché, in un certo qual modo, gli urrasiani temono il contagio ideologico degli odoniani.
Quasi due secoli dopo l’insediamento, Shevek, giovane fisico teorico di Anarres, elabora una geniale teoria generale del tempo e della simultaneità che potrebbe rendere possibile un avanzamento tecnologico altrimenti impossibile. Su Anarres però Shevek non riesce a completare e a divulgare la teoria perché si scontra con il “muro” delle consuetudini scientifiche e sociali che, nella sostanza se non nella forma, creano una struttura gerarchica ostile alle nuove idee. Grazie ad una pubblicazione semi-clandestina, vincerà un premio e verrà accolto su Urras, dove le autorità sperano di sottrarre la sua invenzione e poterci lucrare sopra.
La narrazione è un montaggio alternato di capitoli che funzionano come una struttura di comparazione, attraverso gli occhi del personaggio che da un lato racconta la sua evoluzione su Anarres, fino alla fuga su Urras, e dall’altro la sua permanenza su Urras fino a un esito inatteso.
Al lettore, ogni scelta di Shevek nei capitoli su Anarres può sembrare guidata dall’esperienza accumulata dai capitoli, futuri nel tempo, su Urras, e non solo viceversa – rendendo reale per il lettore l’ipotetica teoria fisica del tempo e della simultaneità. Un contrappunto straniante che racconta la sostanziale uniformità strutturale del potere, indipendentemente dalla sovrastruttura politica che viene imposta nel governo.
L’ambiguità nel romanzo è strutturale e non riguarda solo il superficiale confronto tra i modelli politici diametralmente opposti che finiscono per equivalersi. Il romanzo rifiuta però l’ingenua opposizione tra libertà e coercizione.
Tante, e utili al contesto attuale, le letture di quest’affresco leguiniano. Ad esempio, la vicenda accademica di Shevek è al tempo stesso una teoria del valore di ciò che oggi è Scienza e contemporaneamente un’acuta critica delle istituzioni accademiche moderne. Su Anarres il controllo del pensiero non passa da brevetti e denaro, ma da reputazione e “filtri” soft, impersonificati dal supervisore Sabul che incarna il potere di chi amministra canali e reti: non però un censore ideologico, ma un manutentore della scarsità cognitiva che egli stesso genera. Su Urras, il controllo passa da patronage, proprietà, diplomazia accademica, dal potere dei soldi e dello Stato. Con un efficace uso del chiaroscuro Le Guin dipinge, ad esempio, un affresco in cui per entrambe le società il vero sapere è catturato e reso inefficace da una sovrastruttura di potere con strumenti di cattura e e valvole di sfogo differenti. Amara la considerazione che traspare tra le righe che seppure è vero che la chiusura al sapere diventi sterilità, non basta una apertura, quale che sia cioé senza adeguate garanzie, per non far diventare questo sapere solo uno sfruttamento incivile, che l’autrice rappresenta come l’uso urrasiano della scienza a fini bellici e per la repressione civile.
Qui, l’ambiguità diventa un vincolo etico: obbliga a giudizi locali, a compromessi revocabili, a doveri di manutenzione; ma è un’ambiguità senza relativismo. Questa è la forza del libro oggi: insegna a resistere a protocolli morali binari ed esplorare criteri situati e pronti a essere continuamente riformati.
The Dispossessed è anche una storia sulla solitudine non tanto del genio, ma di tutti noi; sulla difficoltà di dosare opportunamente condivisione e privacy (un’esperienza tragicamente simile all’esposizione nelle reti sociali odierne). È anche una storia sulla diversità, sull’inclusione e sulla costruzione di strutture sociali intenzionali, cioé non obbligate dalla pressione sociale, o che a questa deliberatamente resistono, come i nuclei familiari o i gruppi d’interesse anarresiani.
In questi mondi, Urras e Anarres, dove tutto sembra possibile, per quanto in modi diametralmente opposti, il vivente resta sempre in balia della propria singolarità, della morsa del proprio corpo e, con un bell’esercizio di kantismo radicale, della morale che ha sviluppato dentro di sé.
Alla fine, nel libro non ci sono ricette, ma buone pratiche per la manutenzione istituzionale della libertà. La manutenzione diventa un lavoro invisibile che tiene in vita protocolli e istituzioni: liste, turni, riunioni, comunicazioni anche inattese, correzioni, scuse pubbliche, sanzioni leggere o meno leggere.
Il libro è un invito a considerare valide le consuetudini di protocolli continuamente riformabili, documentati, sottoposti a valutazione collettiva e accordo intersoggettivo. Questo è il cuore di una “lettura anarchica” dell’anarchismo Odoniano che non è assenza di regole, ma una loro artificialità vigilata. Un’artificialità seriamente egualitaria e orientata alla cura, radicate nell’eredità della fondatrice, Odo, che Le Guin dipinge con il suo tipico “tocco” di femminismo anarchico.
Forse c’è anche una morale valida oggi, in questi tempi di opulenza tecno-cognitiva: la materialità di Anarres, pianeta arido con risorse scarse e logistica difficile, crea quest’utopia odoniana praticabile solo per via dalla povertà condivisa e della durezza delle condizioni vitali. Anarres non è certo un paradiso. Invece, l’abbondanza urrasiana diventa continua fonte di guerra e disparità sociale. Nel panorama fantascientifico classico questo capovolge molte utopie tecnologiche. Se la scarsità è elevata a “virtù” teleologica, la critica dell’eccesso tecnologico scivola nel sospetto verso l’innovazione: se l’abbondanza, come è data oggi, diventa madre del “diritto di fare”, non saranno mai visibili i costi “ecologici” ed “egologici” dell’innovazione senza limiti.
Bonus track:
Le Guin, figlia di antropologi, in dialogo con l’ipotesi di relatività linguistica di Sapir-Worf, si dilunga nell’analisi del pravico, la lingua di Anarres, dove il possesso, anche solo grammaticale, è scoraggiato per ridurre lo spazio dell’“egoizzazione”. Il pravico, il cui lessico è la più evidente infrastruttura politica del romanzo, redistribuisce l’attenzione linguistica verso ciò che è condivisibile. Non è un dettaglio di colore, ma un aspetto al tempo stesso tecnologico e teologico di comportamento. Eppure questa lingua progettata per sminuire l’ego, finirà per irrigidirsi in un moralismo del “noi” e diverrà chiaro che la repressione dell’Io produce forme indirette di potere simbolico. Non casualmente per giungere al suo risultato, Shevek dovrà utilizzare lo iotico, ovvero la lingua di A-Io su Urras. L’impressione è che non avrebbe potuto riuscirci in pravico: significa che senza Io anche la cosa che ci sembra più condivisa, come la scienza, si blocca?
—
Ursula K. Le Guin – I reietti dell’altro pianeta
Pubblicato nel 1974, I reietti dell’altro pianeta (The Dispossessed. An Ambiguous Utopia) intreccia l’itinerario del fisico Shevek con il confronto fra due mondi gemelli: Anarres, colonia odoniana anarchica e scarsa di risorse, e Urras, opulento e gerarchico. La scoperta teorica di Shevek — che apre a un fondamentale avanzamento tecnico — diventa il banco di prova per interrogare proprietà del sapere, istituzioni, linguaggio e lavoro: due sistemi che si specchiano e si criticano, senza offrire comode assoluzioni. L’ambiguità qui è un metodo: Le Guin mette in scena come regole, consuetudini e protocolli producano realtà diverse, e come la libertà dipenda dalla capacità di riformarli. Per l’edizione italiana aggiornata si veda Oscar Mondadori; per l’inglese, l’edizione del 50° anniversario con la nuova prefazione di Karen Joy Fowler. (I reietti dell’altro pianeta – Ursula K. Le Guin)
Ursula K. Le Guin (1929–2018)
Scrittrice cardinale della narrativa del secondo Novecento, Le Guin ha costruito cicli diversi per ambizione e tono — dall’Ecumene/Hainish a Earthsea — unendo rigore antropologico, invenzione linguistica e un’attenzione politica mai didascalica. Pluripremiata (Hugo, Nebula, Locus), è fra le pochissime autrici ad aver rinnovato insieme l’utopia politica, il romanzo di formazione e il racconto di mondi “altri”, facendo della lingua e delle istituzioni gli strumenti veri della speculazione. (Ursula K. Le Guin – Scheda autore e Libri)