Titolo: Shadow Libraries. Access to Knowledge in Global Higher Education
Edito da: Joe Karaganis
Editore: The MIT Press
DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/11339.001.0001
ISBN (f. elettr.): 9780262345699
ISBN (f. paperback): 9780262535014
Data di pubblicazione: 2018
Quando nel 2012, Joe Karaganis pubblicò «Media Piracy in Emerging Economies» per il Social Science Research Council (oggi disponibile gratuitamente online in 4 lingue), iniziando un progetto di ricerca sulle alternative non ufficiali alle risorse digitali, registrò che i pirati si concentravano sui materiali più standardizzati e di largo consumo, come musica e film, e che stavano iniziando a raccogliere la produzione libraria narrativa o tecnica, ma che il campo della produzione accademica, come riviste, monografie o raccolte di articoli, fosse ben poco affetto da queste pratiche.
Joe Karaganis, che è vicepresidente di The American Assembly, un istituto di politiche pubbliche presso la Columbia University, sapeva bene che il mercato dell’editoria accademica si trovava già in una posizione notevolmente più esposta alle critiche rispetto all’editoria degli altri settori, perché lo sviluppo delle pratiche di pubblicazione raramente remunerava direttamente gli autori e inoltre gli editori si trovavano nell’invidiabile condizione di essere pagati fino a tre volte per il loro impegno (parte del quale era scaricato poi a costo zero sulla comunità accademica stessa, come la selezione e la revisione). Venivano remunerati una volta dagli autori che spesso direttamente o indirettamente pagavano la pubblicazione dei loro volumi e dei lavori di ricerca spesso con fondi pubblici, una seconda volta dalle biblioteche pubbliche e private, che pagavano la seconda volta lo stesso materiale spesso a costi maggiorati e anche qui con fondi pubblici o ottenuti con la raccolta delle donazioni private ad esempio nel mondo anglosassone e infine, la terza volta, dai clienti che acquistavano il materiale attraverso il normale circuito di distribuzione.
Nonostante questo, il ricorso a pratiche di distribuzione alternativa era, secondo Karaganis, disincentivato da alcuni fattori come la frammentazione del sistema produttivo dell’informazione accademica, le pratiche commerciali degli editori molto benevole verso il mondo accademico, ampie esenzioni al copyright e il sostanziale buon funzionamento delle organizzazioni di distribuzione intermedia, come le biblioteche universitarie.
Dopo meno di 10 anni la situazione è drasticamente cambiata e Karaganis lo ha registrato in questo nuovo volume nel suo programma di ricerca «Shadow Libraries: Access to Knowledge in Global Higher Education» (MIT Press, 2018).
Non solo sono fioriti organizzatissimi siti pirata per la distribuzione di materiale accademico ma sono diventati velocemente anche il primario strumento per le ricerche bibliografiche e per l’accesso diretto ai materiali, e non solo nei paesi a basso e medio reddito in cui si è di recente maggiormente sviluppata la popolazione studentesca, come l’India, dove è quadruplicata, il Brasile, dove è triplicata, e Messico e Sud Africa dove è più che raddoppiata. Le pratiche di uso delle librerie ombra in questi paesi costituiscono i casi di studio presentati nei vari capitoli del libro.
Difficilmente queste pratiche possono essere etichettate come «buone pratiche» in campo accademico, ma certamente sono di gran lunga più efficaci delle alternative ufficiali e legali e spesso rappresentano l’unica possibilità per alcuni paesi che non possono permettersi gli alti costi imposti dall’editoria accademica di affrontare il problema, sempre più rilevante, del divario per l’accesso alla conoscenza tra paesi poveri e ricchi.
In questi anni infatti il campo dell’editoria accademica ha risentito di alcuni fattori rilevanti: 1) il disinvestimento nelle istituzioni educative ha reso la loro opera molto meno efficace che in passato, anche per 2) la rapacità commerciale degli editori che hanno costantemente aumentato i prezzi per riviste e monografie, aiutati 3) dalla riduzione della concorrenza dovuta alla continua concentrazione e acquisizione.
La presenza di questi siti però rende evidente come, complessivamente, il settore dell’editoria accademica risulti grossolanamente inadeguato alle esigenze moderne di accesso alla conoscenza scientifica di livello superiore, anche nei paesi a maggior reddito, e che, sebbene questa risposta pirata risulti essere altrettanto grossolanamente inadeguata per la tutela dei diritti degli editori (mentre gli autori spesso non hanno diritti economici), serve di gran lunga meglio l’esigenza di accesso e condivisione all’informazione accademica.
Karaganis riassume il tema portante del problema in un lungo ed efficace capitolo introduttivo in cui esplicita i fattori che portano all’uso di queste vaste collezioni ombra in particolare nei paesi meno abbienti: un mercato disfunzionale in cui i materiali finiscono per non essere proprio disponibili poiché scompaiono dai cataloghi, non vengono ristampati o offerti in versione digitale, e quando sono presenti vengono messi in commercio con prezzi troppo ed immotivatamente cari; una popolazione studentesca in rapido aumento, affamata di conoscenza di qualità; e un facile accesso alla tecnologia necessaria a copia e di condivisione.
I due migliori capitoli del libro sono quelli in cui Balázs Bodó presenta l’ingegnosità con cui i bibliotecari ombra di LibGen e Sci-Hub hanno modellato i sistemi per essere virtualmente inattaccabili dal punto di vista tecnico e legale, sulla base del modello delle reti anti-censura e samizdat in Russia. L’adozione di avanzate tecniche di dissimulazione, distribuzione e forking, nonché lo sviluppo di strumenti di indicizzazione e hosting virtuale permettono ai siti di offrire risultati anche quando interi server dovessero essere staccati dalla rete senza preavviso. Il punto forse più rilevante dell’intero studio è l’affermazione che l’aggregazione di materiali accademici è in tal modo diventata una comune pratica comunitaria per i ricercatori di ogni livello, che «la grande maggioranza degli studenti… si sono trasformati in bibliotecari ombra per necessità, se non per scelta» (p. 206).
La battaglia è ancora in corso, come testimoniano i sei capitoli sulle esperienze in Argentina, Sud Africa, Polonia, India, Brasile e Uruguay. Già partire dalla fine degli anni ’90, gli editori di media tradizionali (specialmente di musica e film) si sono impegnati in una battaglia globale contro la distribuzione commerciale o gratuita dei loro prodotti senza al contempo fare alcunché per migliorare la propria fruibilità della propria offerta e per rendere i prezzi più adeguati alla situazione tecnologica. Hanno ottenuto di essere prima surclassati e poi sostanzialmente fagocitati da un nuovo tipo di operatori del mercato dei media, le piattaforme online basate sul modello peer-to-peer come Youtube, Netflix, Amazon Prime, Hulu ecc, discendenti diretti, come mentalità e tecnologia, delle reti pirata peer-to-peer.
L’autore suggerisce che il riflesso degli editori accademici non sembra oggi essere differente. Le azioni antipirateria erano iniziate addirittura un decennio prima, alla fine degli anni ’80, quando la tecnologia fotostatica aveva dato un impulso alla copia illegale su carta. Poi avevano subito una stasi dovuta soprattutto alla pessima pubblicità che se ne ricavava, per poi essere riprese nell’ultimo decennio contro le collezioni distribuite su Internet.
Gli editori, piuttosto che rendere più efficiente e fruibile il mercato legale delle risorse, promuovendo una distribuzione meno frammentata, macchinosa e soprattutto costosa, si sono concentrati nel colpire lo scambio illegale facendo ricorso soprattutto alle risorse economiche pubbliche, grazie al fatto che, attraverso pesanti azioni di lobbying, sono riuscite a criminalizzare penalmente quello che, a tutti gli effetti è solo la rottura di un contratto privato.
Ma l’attacco frontale e globale alla pirateria e ai suoi pochi portavoce visibili, come ad esempio Alexandra Elbakyan, che ha fondato e dirige la più famosa biblioteca ombra di Internet, Sci-Hub, si è trasformato in una debacle non solo nel campo delle public relation, ma anche giuridica.
Molti paesi, specie quelli a basso e medio reddito, hanno esteso significativamente le eccezioni del copyright a favore dell’uso in campo educativo, oppure hanno imposto agli editori obblighi di identificazione molto stringenti nelle pretese di tutela del materiale coperto da privative di copia.
In definitiva l’approccio truce degli editori non ha neppure superficialmente scalfito il problema però è riuscita persino a fare vittime umane, come nel caso tragico del suicidio nel 2013 del giovane ricercatore «prodigio» Aaron Swartz, creatore tra l’altro della Open Library su Internet Archive, su cui, aggravate dalle autorità USA perché diventasse un caso definitivo e esemplare nel campo del copyright, piombarono accuse gravissime e la minaccia di oltre 35 anni di detenzione per aver scaricato articoli di pubblico dominio precedenti al 1923 da JSTOR sulla rete universitaria del MIT.
Il libro di Karaganis suggerisce che il modello pirata potrà essere soppiantato da un’offerta legale, quando questa proverrà da operatori differenti da quelli dell’attuale editoria, e sarà modellata sulle tecnologie molto efficienti delle shadow library e preveda costi minimi, addirittura alla portata del singolo studente, esattamente come le reti peer-to-peer per il materiale audiovisivo hanno modellato la strutturazione tecnologica delle nuove piattaforme legali di distribuzione di film e musica.
Questo modello crea una sfida non solo all’editoria accademica, che troppo tardi, con grandi ambiguità e troppo lentamente si sta avviando su quella strada alternativa che potrebbe essere l’open access, ma anche a tutto l’ambiente circostante, come quello delle biblioteche universitarie e non, il cui ruolo di mero depositario di pubblicazioni verrebbe ridimensionato, imponendo l’esigenza di drastiche innovazioni. Il costo del licensing dei prodotti editoriali sale vertiginosamente mentre i budget di queste istituzioni decresce, orientandosi sempre più spesso nell’acquisto di licenze limitate e periodiche per prodotti che facilmente svaniscono dai cataloghi o quando non si paga più o se il panorama tecnologico muta.
Le shadow library possono essere considerate la risposta autoorganizzata, cooperativa e sostanzialmente anarchica, ai forti disinvestimenti pubblici nel campo dell’istruzione e delle sue istituzioni, all’instabilità dei prodotti editoriali che, specialmente per quelli digitali, possono essere fatti sparire dagli editori, non solo nei propri cataloghi, ma addirittura dai dispositivi degli utenti. Ma queste raccolte, forse ancora di più, sono una risposta alla mancata difesa da parte del potere pubblico del diritto di accesso libero e poco costoso alla conoscenza, per favorire un modello rapace di proprietà intellettuale che concentra le risorse conoscitive in grandi conglomerati e rende ancora più sensibile il divario digitale tra gli abbienti e i meno abbienti.
Il libro di Karaganis riconosce alcuni difetti delle attuali biblioteche ombra, oltre quello ovvio della gestione del copyright. In particolar modo la carenza di assicurazione della qualità delle risorse, sia in termini tecnici (ad esempio, qualità e completezza delle scansioni), ma soprattutto l’assenza di ogni riferimento alla qualità accademica delle pubblicazioni distribuite che sono tutte trattate allo stesso modo, mettendo assieme ricerca peer-reviewed di alta qualità proveniente da fonti prestigiose e materiale molto discutibile.
Queste carenze saranno eliminabili dal punto di vista tecnico con un’opera di selezione e categorizzazione realizzata in crowdsourcing o attraverso tecniche avanzate di intelligenza artificiale e machine learning, ma rimane il problema della sostenibilità di lungo periodo del modello che non prevede di remunerare direttamente le figure non inutili del processo di lavorazione dell’informazione accademica.
Alcuni difetti invece sono riscontrabili nell’edizione del libro, primo tra tutti l’uso di fonti non persistenti nelle citazioni (DOI, handle, ecc) e il riferimento a siti che sono ormai già spariti dal Web e mancano di archiviazione su Internet Archive o Perma.cc. Questo è un peccato perché mutila il valore di una ricerca che per altri versi è veramente molto ben condotta.
Al di là delle vuote affermazioni di principio, mantenere alti gli ostacoli materiali alla diffusione della conoscenza superiore può essere forse un interesse delle elite nei paesi più ricchi, ma, come chiaramente mostrano le ricerche delle realtà locali citate nel libro, non lo è certamente per i paesi democratici a basso e medio reddito dove l’istruzione rappresenta la principale fonte di crescita e mobilità sociale individuale.
Recentemente alcune blasonate istituzioni educative occidentali hanno iniziato, e vantano, estesi programmi transnazionali di diffusione dei loro programmi educativi, a bassissimo costo o addiritura gratuiti, come contributo alla diffusione delle cultura superiore anche in zone del mondo meno avvantaggiate, senza probabilmente accorgersi che i libri adottati, se si volessero comprare legalmente, spesso costerebbero cifre esorbitanti e totalmente fuori dalla portata dei potenziali studenti di questi paesi. Difficile immaginare che questi stessi corsi a basso costo non siano diventato il migliore spot pubblicitario possibile per l’esistenza e l’evoluzione delle shadow library.
Il libro «Shadow Libraries: Access to Knowledge in Global Higher Education» è disponibile per il prestito in biblioteca Paolo Baffi, online gratuitamente come Open Access e, ovviamente, nelle principali shadow libraries.
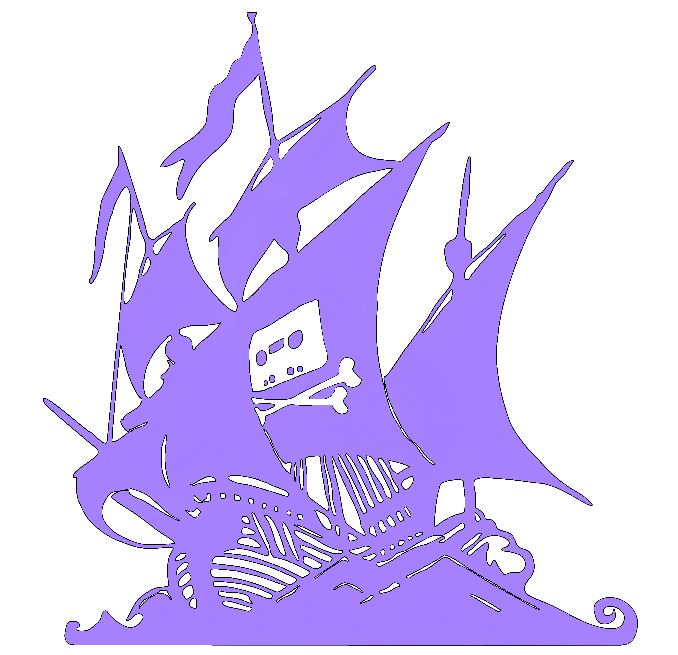
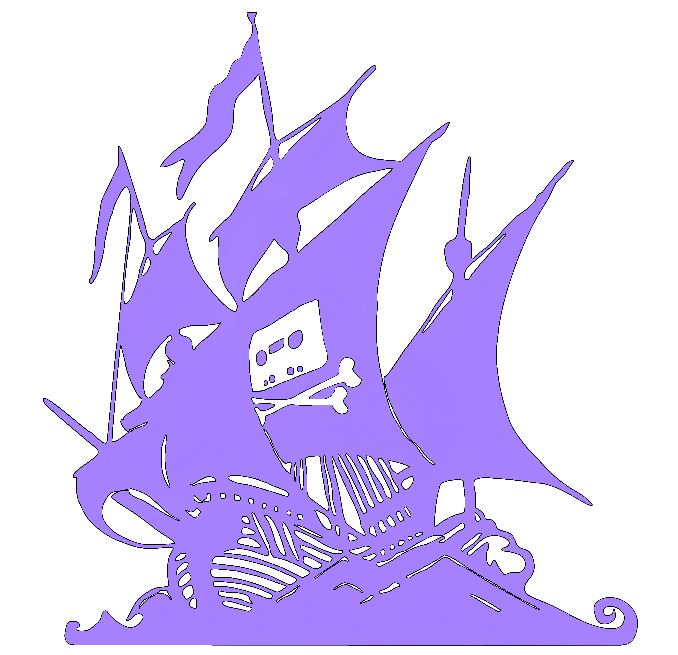
Quando nel 2012, Joe Karaganis pubblicò «Media Piracy in Emerging Economies» per il Social Science Research Council (oggi disponibile gratuitamente online in 4 lingue), iniziando un progetto di ricerca sulle alternative non ufficiali alle risorse digitali, registrò che i pirati si concentravano sui materiali più standardizzati e di largo consumo, come musica e film, e che stavano iniziando a raccogliere la produzione libraria narrativa o tecnica, ma che il campo della produzione accademica, come riviste, monografie o raccolte di articoli, fosse ben poco affetto da queste pratiche.
Joe Karaganis, che è vicepresidente di The American Assembly, un istituto di politiche pubbliche presso la Columbia University, sapeva bene che il mercato dell’editoria accademica si trovava già in una posizione notevolmente più esposta alle critiche rispetto all’editoria degli altri settori, perché lo sviluppo delle pratiche di pubblicazione raramente remunerava direttamente gli autori e inoltre gli editori si trovavano nell’invidiabile condizione di essere pagati fino a tre volte per il loro impegno (parte del quale era scaricato poi a costo zero sulla comunità accademica stessa, come la selezione e la revisione). Venivano remunerati una volta dagli autori che spesso direttamente o indirettamente pagavano la pubblicazione dei loro volumi e dei lavori di ricerca spesso con fondi pubblici, una seconda volta dalle biblioteche pubbliche e private, che pagavano la seconda volta lo stesso materiale spesso a costi maggiorati e anche qui con fondi pubblici o ottenuti con la raccolta delle donazioni private ad esempio nel mondo anglosassone e infine, la terza volta, dai clienti che acquistavano il materiale attraverso il normale circuito di distribuzione.
Nonostante questo, il ricorso a pratiche di distribuzione alternativa era, secondo Karaganis, disincentivato da alcuni fattori come la frammentazione del sistema produttivo dell’informazione accademica, le pratiche commerciali degli editori molto benevole verso il mondo accademico, ampie esenzioni al copyright e il sostanziale buon funzionamento delle organizzazioni di distribuzione intermedia, come le biblioteche universitarie.
Dopo meno di 10 anni la situazione è drasticamente cambiata e Karaganis lo ha registrato in questo nuovo volume nel suo programma di ricerca «Shadow Libraries: Access to Knowledge in Global Higher Education» (MIT Press, 2018).
Non solo sono fioriti organizzatissimi siti pirata per la distribuzione di materiale accademico ma sono diventati velocemente anche il primario strumento per le ricerche bibliografiche e per l’accesso diretto ai materiali, e non solo nei paesi a basso e medio reddito in cui si è di recente maggiormente sviluppata la popolazione studentesca, come l’India, dove è quadruplicata, il Brasile, dove è triplicata, e Messico e Sud Africa dove è più che raddoppiata. Le pratiche di uso delle librerie ombra in questi paesi costituiscono i casi di studio presentati nei vari capitoli del libro.
Difficilmente queste pratiche possono essere etichettate come «buone pratiche» in campo accademico, ma certamente sono di gran lunga più efficaci delle alternative ufficiali e legali e spesso rappresentano l’unica possibilità per alcuni paesi che non possono permettersi gli alti costi imposti dall’editoria accademica di affrontare il problema, sempre più rilevante, del divario per l’accesso alla conoscenza tra paesi poveri e ricchi.
In questi anni infatti il campo dell’editoria accademica ha risentito di alcuni fattori rilevanti: 1) il disinvestimento nelle istituzioni educative ha reso la loro opera molto meno efficace che in passato, anche per 2) la rapacità commerciale degli editori che hanno costantemente aumentato i prezzi per riviste e monografie, aiutati 3) dalla riduzione della concorrenza dovuta alla continua concentrazione e acquisizione.
La presenza di questi siti però rende evidente come, complessivamente, il settore dell’editoria accademica risulti grossolanamente inadeguato alle esigenze moderne di accesso alla conoscenza scientifica di livello superiore, anche nei paesi a maggior reddito, e che, sebbene questa risposta pirata risulti essere altrettanto grossolanamente inadeguata per la tutela dei diritti degli editori (mentre gli autori spesso non hanno diritti economici), serve di gran lunga meglio l’esigenza di accesso e condivisione all’informazione accademica.
Karaganis riassume il tema portante del problema in un lungo ed efficace capitolo introduttivo in cui esplicita i fattori che portano all’uso di queste vaste collezioni ombra in particolare nei paesi meno abbienti: un mercato disfunzionale in cui i materiali finiscono per non essere proprio disponibili poiché scompaiono dai cataloghi, non vengono ristampati o offerti in versione digitale, e quando sono presenti vengono messi in commercio con prezzi troppo ed immotivatamente cari; una popolazione studentesca in rapido aumento, affamata di conoscenza di qualità; e un facile accesso alla tecnologia necessaria a copia e di condivisione.
I due migliori capitoli del libro sono quelli in cui Balázs Bodó presenta l’ingegnosità con cui i bibliotecari ombra di LibGen e Sci-Hub hanno modellato i sistemi per essere virtualmente inattaccabili dal punto di vista tecnico e legale, sulla base del modello delle reti anti-censura e samizdat in Russia. L’adozione di avanzate tecniche di dissimulazione, distribuzione e forking, nonché lo sviluppo di strumenti di indicizzazione e hosting virtuale permettono ai siti di offrire risultati anche quando interi server dovessero essere staccati dalla rete senza preavviso. Il punto forse più rilevante dell’intero studio è l’affermazione che l’aggregazione di materiali accademici è in tal modo diventata una comune pratica comunitaria per i ricercatori di ogni livello, che «la grande maggioranza degli studenti… si sono trasformati in bibliotecari ombra per necessità, se non per scelta» (p. 206).
La battaglia è ancora in corso, come testimoniano i sei capitoli sulle esperienze in Argentina, Sud Africa, Polonia, India, Brasile e Uruguay. Già partire dalla fine degli anni ’90, gli editori di media tradizionali (specialmente di musica e film) si sono impegnati in una battaglia globale contro la distribuzione commerciale o gratuita dei loro prodotti senza al contempo fare alcunché per migliorare la propria fruibilità della propria offerta e per rendere i prezzi più adeguati alla situazione tecnologica. Hanno ottenuto di essere prima surclassati e poi sostanzialmente fagocitati da un nuovo tipo di operatori del mercato dei media, le piattaforme online basate sul modello peer-to-peer come Youtube, Netflix, Amazon Prime, Hulu ecc, discendenti diretti, come mentalità e tecnologia, delle reti pirata peer-to-peer.
L’autore suggerisce che il riflesso degli editori accademici non sembra oggi essere differente. Le azioni antipirateria erano iniziate addirittura un decennio prima, alla fine degli anni ’80, quando la tecnologia fotostatica aveva dato un impulso alla copia illegale su carta. Poi avevano subito una stasi dovuta soprattutto alla pessima pubblicità che se ne ricavava, per poi essere riprese nell’ultimo decennio contro le collezioni distribuite su Internet.
Gli editori, piuttosto che rendere più efficiente e fruibile il mercato legale delle risorse, promuovendo una distribuzione meno frammentata, macchinosa e soprattutto costosa, si sono concentrati nel colpire lo scambio illegale facendo ricorso soprattutto alle risorse economiche pubbliche, grazie al fatto che, attraverso pesanti azioni di lobbying, sono riuscite a criminalizzare penalmente quello che, a tutti gli effetti è solo la rottura di un contratto privato.
Ma l’attacco frontale e globale alla pirateria e ai suoi pochi portavoce visibili, come ad esempio Alexandra Elbakyan, che ha fondato e dirige la più famosa biblioteca ombra di Internet, Sci-Hub, si è trasformato in una debacle non solo nel campo delle public relation, ma anche giuridica.
Molti paesi, specie quelli a basso e medio reddito, hanno esteso significativamente le eccezioni del copyright a favore dell’uso in campo educativo, oppure hanno imposto agli editori obblighi di identificazione molto stringenti nelle pretese di tutela del materiale coperto da privative di copia.
In definitiva l’approccio truce degli editori non ha neppure superficialmente scalfito il problema però è riuscita persino a fare vittime umane, come nel caso tragico del suicidio nel 2013 del giovane ricercatore «prodigio» Aaron Swartz, creatore tra l’altro della Open Library su Internet Archive, su cui, aggravate dalle autorità USA perché diventasse un caso definitivo e esemplare nel campo del copyright, piombarono accuse gravissime e la minaccia di oltre 35 anni di detenzione per aver scaricato articoli di pubblico dominio precedenti al 1923 da JSTOR sulla rete universitaria del MIT.
Il libro di Karaganis suggerisce che il modello pirata potrà essere soppiantato da un’offerta legale, quando questa proverrà da operatori differenti da quelli dell’attuale editoria, e sarà modellata sulle tecnologie molto efficienti delle shadow library e preveda costi minimi, addirittura alla portata del singolo studente, esattamente come le reti peer-to-peer per il materiale audiovisivo hanno modellato la strutturazione tecnologica delle nuove piattaforme legali di distribuzione di film e musica.
Questo modello crea una sfida non solo all’editoria accademica, che troppo tardi, con grandi ambiguità e troppo lentamente si sta avviando su quella strada alternativa che potrebbe essere l’open access, ma anche a tutto l’ambiente circostante, come quello delle biblioteche universitarie e non, il cui ruolo di mero depositario di pubblicazioni verrebbe ridimensionato, imponendo l’esigenza di drastiche innovazioni. Il costo del licensing dei prodotti editoriali sale vertiginosamente mentre i budget di queste istituzioni decresce, orientandosi sempre più spesso nell’acquisto di licenze limitate e periodiche per prodotti che facilmente svaniscono dai cataloghi o quando non si paga più o se il panorama tecnologico muta.
Le shadow library possono essere considerate la risposta autoorganizzata, cooperativa e sostanzialmente anarchica, ai forti disinvestimenti pubblici nel campo dell’istruzione e delle sue istituzioni, all’instabilità dei prodotti editoriali che, specialmente per quelli digitali, possono essere fatti sparire dagli editori, non solo nei propri cataloghi, ma addirittura dai dispositivi degli utenti. Ma queste raccolte, forse ancora di più, sono una risposta alla mancata difesa da parte del potere pubblico del diritto di accesso libero e poco costoso alla conoscenza, per favorire un modello rapace di proprietà intellettuale che concentra le risorse conoscitive in grandi conglomerati e rende ancora più sensibile il divario digitale tra gli abbienti e i meno abbienti.
Il libro di Karaganis riconosce alcuni difetti delle attuali biblioteche ombra, oltre quello ovvio della gestione del copyright. In particolar modo la carenza di assicurazione della qualità delle risorse, sia in termini tecnici (ad esempio, qualità e completezza delle scansioni), ma soprattutto l’assenza di ogni riferimento alla qualità accademica delle pubblicazioni distribuite che sono tutte trattate allo stesso modo, mettendo assieme ricerca peer-reviewed di alta qualità proveniente da fonti prestigiose e materiale molto discutibile.
Queste carenze saranno eliminabili dal punto di vista tecnico con un’opera di selezione e categorizzazione realizzata in crowdsourcing o attraverso tecniche avanzate di intelligenza artificiale e machine learning, ma rimane il problema della sostenibilità di lungo periodo del modello che non prevede di remunerare direttamente le figure non inutili del processo di lavorazione dell’informazione accademica.
Alcuni difetti invece sono riscontrabili nell’edizione del libro, primo tra tutti l’uso di fonti non persistenti nelle citazioni (DOI, handle, ecc) e il riferimento a siti che sono ormai già spariti dal Web e mancano di archiviazione su Internet Archive o Perma.cc. Questo è un peccato perché mutila il valore di una ricerca che per altri versi è veramente molto ben condotta.
Al di là delle vuote affermazioni di principio, mantenere alti gli ostacoli materiali alla diffusione della conoscenza superiore può essere forse un interesse delle elite nei paesi più ricchi, ma, come chiaramente mostrano le ricerche delle realtà locali citate nel libro, non lo è certamente per i paesi democratici a basso e medio reddito dove l’istruzione rappresenta la principale fonte di crescita e mobilità sociale individuale.
Recentemente alcune blasonate istituzioni educative occidentali hanno iniziato, e vantano, estesi programmi transnazionali di diffusione dei loro programmi educativi, a bassissimo costo o addiritura gratuiti, come contributo alla diffusione delle cultura superiore anche in zone del mondo meno avvantaggiate, senza probabilmente accorgersi che i libri adottati, se si volessero comprare legalmente, spesso costerebbero cifre esorbitanti e totalmente fuori dalla portata dei potenziali studenti di questi paesi. Difficile immaginare che questi stessi corsi a basso costo non siano diventato il migliore spot pubblicitario possibile per l’esistenza e l’evoluzione delle shadow library.
Il libro «Shadow Libraries: Access to Knowledge in Global Higher Education» è disponibile per il prestito in biblioteca Paolo Baffi, online gratuitamente come Open Access e, ovviamente, nelle principali shadow libraries.